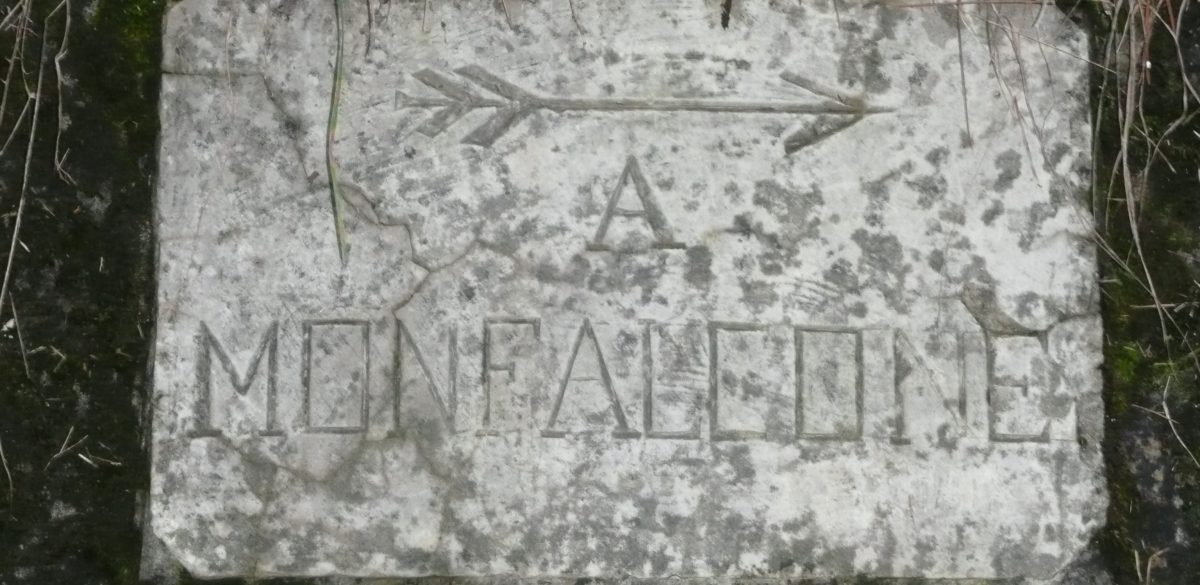Folli prìncipi e sovrani (1)
Lavorando da otto anni all’interno del settore psichiatria di questa cooperativa, mi sono potuto confrontare da prospettive e distanze variabili, con la follia, e coi suoi rappresentanti terreni, secolarizzati secondo una costellazione di termini più o meno politicamente corretti che spesso testimoniano solo il tipo di aspettativa che nutriamo su di loro: i pazzi, i malati, i matti, i folli, i pazienti, gli utenti, gli ospiti, i ragazzi, i signori, ecc. Col passare del tempo, questi nomi sono entrati nel mio “vocabolario professionale”, riempiendosi di significati, di sfumature, di sensi mai neutri, di giudizi e pregiudizi.
Questi nomi riferiscono ai soggetti (ma più spesso agli oggetti) sui quali il potere psichiatrico si è a lungo applicato in modo multiforme, imprevedibile e variabile, modulandosi come solo il potere sa fare e cercando in ultimo di trovare valido appoggio anche in me e nei miei colleghi, gli operatori psichiatrici, le ultime ruote del carro, sulle quali la macchina della psichiatria traballa lungo la sua strada.
Dopo anni di confronto con la follia e con chi tratta con la stessa dall’altra parte del tavolo (quella da cui si prende il bicchierino con le pastiglie), sono giunto a una sola conclusione plausibile che ho ritrovato felicemente espressa nelle parole di un filosofo. Pieraldo Rovatti, in un libro nato successivamente a un attento confronto con gli operatori del settore psichiatrico, sostiene che l’ unico concetto ancora capace di dare un significato alla follia sia il seguente: “non so” (Rovatti, 2000). Secondo Rovatti “non so” è l’unica espressione che forse può dirci ancora qualcosa di non banale sulla follia e che può racchiuderne l’essenza.
“Non so”. E’ facile per un filosofo concludere con queste parole l’analisi della questione, ma posso io, operatore psichiatrico, accettare il fatto di “non sapere” con cosa mi procuro il pane ogni giorno dormendoci sopra sonni tranquilli? Per capirci con un esempio: pochi di noi tornerebbero a curarsi la tonsillite dallo stesso specialista che alla prima visita gli avesse fatto calare le braghe, e nel caso, possiamo dubitare che lo farebbero per la professionalità del dottore.
Possiamo allora noi ritenerci utili alle persone che frequentano la follia dall’altra parte del tavolo quando l’unica cosa che sappiamo dire a riguardo è “non so”? O non potrebbe essere che questa mancanza, questo vuoto di conoscenza, sia invece una condizione determinante per il nostro stesso lavoro?
Sapere e potere
Uno tra gli assunti della nostra società è dato dalla coppia “sapere e potere”, valori che si affermano in particolare con Pico della Mirandola e con Bacone, amplificando una sete di conoscenza speculativa che in Occidente era gà cominciata ai tempi di Aristotele. Questi due tratti distintivi della nostra civiltà sono profondamente connessi con la convinzione che la ragione umana (la ratio) possa organizzare il mondo secondo i suoi schemi e le sue logiche. Lo stesso sviluppo della società industriale moderna sarebbe da attribuire alla riorganizzazione del mondo secondo uno schema perfetto nato in un’epoca in cui i lumi della ragione vennero esaltati così tanto che ne determinarono il nome: l’Illuminismo.
Fu proprio un illuminista, Jeremy Bentham (giurista e filosofo di ampie vedute che a finire del XVIII secolo combattè battaglie d’avanguardia per la fine della schiavitù, la difesa dei diritti delle donne e degli omosessuali, la divisione tra Chiesa e Stato, il diritto al divorzio, l’abolizione delle pene corporali e la difesa dei diritti degli animali), a proporre un modello razionale di organizzazione dello spazio atto a garantire l’applicazione dei saperi sui corpi umani, al fine di massimizzarne la resa nei due luoghi nevralgici della civiltà occidentale: la caserma e la fabbrica. La sua invenzione passò alla storia col nome di panopticon. Consisteva in una struttura achitettonica con un punto centrale di osservazione, da cui un controllore non visibile poteva osservare perennemente i corpi e i movimenti dei suoi sottoposti. Corpi controllati, disciplinati e sani che producevano e marciavano al ritmo scandito dai loro capi, e dai capi di questi ultimi attraverso un ordine gerarchico che, percorso a ritroso, avrebbe condotto presso l’ordinatissimo controllore del Tutto; l’Essere Supremo, descritto di fatto dalla nostra tradizione come un’entità che tutto vede e conosce.
Questa oliata macchina sociale si inceppava però su alcuni ingranaggi poco funzionali: figure sulle quali la disciplina produttiva sembrava potere ben poco; le stesse su cui il potere normativo sembra avere ancora oggi alcune difficoltà: alcolizzati, delinquenti di vario rango, prostitute, vagabondi e altri sbandati, pazzi. Lungi dall’ignorare questi scomodi personaggi, la società dell’epoca li collocò nella categoria astratta della anormalità e conseguentemente entro appositi luoghi dotati di concrete e spesse mura chiuse da altrettanto concreti cancelli. Carceri, riformatori, ospedali , manicomi, collegi; queste le istituzioni in cui la società moderna rinchiuse i corpi degli anormali, interrogandoli sul perché costoro non si piegassero ai suoi dogmi impedendole di realizzare il suo sogno.
Su queste vite marginali, in particolare sui folli, che evidentemente già allora sembravano saperla lunga, il potere finì con l’iscrivere uno stigma che ne testimoniava l’incapacità di stare al ritmo degli altri, attestandone la devianza e l’irriducibilità alle comuni regole del vivere civile. Su costoro, prova vivente della fine del sogno di un mondo razionale e perfetto, continuiamo ancora a riversare molte delle nostre paure, quelle dell’alterità e della morte su tutte.
Corpi
Quello del potere è un concetto controverso e di complessa trattazione. Pensare di scalfirne la corazza con queste poche righe sarebbe impossibile. Tuttavia, lasciando in piedi tutte le plausibili interpretazioni sull’argomento, riporto qui una sola certezza: il potere ha bisogno di corpi sui quali attecchire. I matti marchiati dallo stigma della follia, hanno riempito con infinita sopportazione i manicomi, prestando i loro corpi alla rappresentazione delle incognite più inquietanti per la nostra società. I corpi dei matti…
Noi operatori psichiatrici sappiamo bene quello di cui si sta trattando, e non solo chi tra noi ha esperienza di istituzione totale. Conosciamo i corpi dei matti, li frequentiamo quotidianamente, vestiti o nudi che siano. Li conosciamo come li conosce l’istituzione che li ha a lungo interrogati recludendoli, sezionandoli e sottoponendoli alle domande dei suoi saperi. Li conosciamo perchè noi stessi a nostro modo siamo parte di quella istituzione.
Prendiamo per esempio il lavarsi, atto rituale da sempre legato alla purificazione e alla rigenerazione che viene compiuto in modo attento, personale e intimo. Eppure a volte gli utenti, in particolare coloro i quali hanno conosciuto il manicomio, ci stupiscono per la mancanza di pudore con cui condividono la loro nudità. Si espongono innocentemente, insaponandosi con cura, e in genere, quando meno ce lo aspettiamo, con una mossa che supponiamo involontaria, girano d’improvviso nella nostra direzione il getto d’acqua, generalmente bollente o ghiacciata, che ci colpisce in pieno.
Noi cerchiamo di rimediare con un brandello di asciugamano, ed ecco che la porta si spalanca e un altro ospite compare come per magia e si siede sulla tazza senza badare affatto a noi che lo imploriamo di andarsene. Mentre lui, monumentale, continua a ignorarci, ecco che il secondo getto ci colpisce alla nuca e non abbiamo avuto neppure il tempo di realizzarne la temperatura che già escono entrambi come se niente fosse, dirigendosi verso le rispettive camere e lasciandoci soli, in mezzo al bagno allagato, in balia di un terzo soggetto che, con la flemma di un lord inglese, richiede la paghetta giornaliera.
L’esempio che ho riportato è abituale in alcune strutture, e non è logicamente presente in tutte le realtà. Mi aiuta però a porre una questione più generale. Oltre ai quattro protagonisti che ho sopra menzionato, è qui in azione un ulteriore convitato; un intruso la cui presenza, necessaria e invasiva, opera tanto nei corpi e nei comportamenti degli ospiti quanto in quelli degli operatori. Si tratta dell’istituzione: dell’organo invisibile deputato alla gestione del potere e del sapere.
De-istituzione
L’istituzione psichiatrica, come ogni tipo di istituzione non è di per se né buona né cattiva; ha piuttosto la caratteristica di “immunizzare”, riprendendo l’espressione del filosofo napoletano Esposito (Esposito, 2004), ossia di togliere dall’esperienza. Essa insomma tende a privare le persone dalla possibilità di poter disporre pienamente di sè e rischia di plasmare la vita di chi le viene sottoposto secondo modelli (per l’appunto) istituzionali. E’ frequente dunque che chi ha conosciuto l’istituzione della psichiatria abbia delegato progressivamente se stesso, i propri desideri, le sue emozioni e le sue aspettative, a quella cosa che sottrarre e tutela dall’esperienza in modo direttamente proporzionale all’altezza delle mura (reali o simboliche) con cui contiene i soggetti.
Quei corpi nudi a cui ci affianchiamo a volte (pur con le differenze del caso), come ebbe malauguratamente modo di appurare lo psicologo Victor E. Frankl scampato ai campi di concentramento nazisti, altro non sono, spesso, che l’ultimo baluardo che si erge prima di una completa deprivazione della persona: un confine a volte già diventato terra di nessuno.
“Non so” si era detto alcune righe più sopra, è una tra le cose meno banali che si possono dire riguardo alla follia. “Non sappiamo” cosa pensare quando ci troviamo lì, al centro del bagno assistendo con sconcerto quello che accade attorno a noi, oppure quando l’inserimento lavorativo dato per sicuro fallisce, quando “la crisi” si ripresenta a richiudere il margine di contatto che si era creato, o quando la riabilitazione prende strade inaspettate e spiazzanti. Eppure, quando l’unica cosa che ci passa per la testa bagnata è quel “non so”, ecco che forse l’istituzione vacilla, il suo potere si incrina nei nostri corpi e nei corpi degli ospiti, lasciando nelle nostre certezze un pertugio in cui può insinuarsi un rapporto dialettico tra diversità.
L’istituzione pare aprirsi sopra un vuoto contraddittorio che chiede di essere riempito e risignificato, sopra quel “non so” che può portare, anche per un solo istante, a una contrattualità spogliata del peso di un rapporto di potere, L’antropolgo Claude Levi Strauss, confrontatosi con civiltà estranee a quella occidentale, sostiene che anche in luoghi culturalmente distantissimi dai nostri, il potere della struttura, per molti aspetti simile a quello che intendiamo noi per potere istituzionale, blocca e codifica rigidamente le relazioni umane. Levi Strauss, e con lui Turner, sostiene che solo una persona priva di status può essere capace di ricevere la “gnosis” tribale contribuendo così a una riflessione sapienziale “che coinvolge le strutture base della mente e del pensiero umano” (Turner, 1972). Ma è davvero possibile che l’istituzione possa aprirsi e contaminarsi col germe della follia?
Bibliografia
BAUDRILLARD J. – Lo scambio simbolico e la morte, Milano, Feltrinelli, 2002
BAUMAN Z. – La società dell’incertezza, Bologna, Il Mulino, 1999
ESPOSITO R. – Bios, biopolitica e filosofia, Torino, Einaudi, 2004
FOUCAULT M. – Sorvegliare e punire, nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1976
FOUCAULT M. – Follia e psichiatria, detti e scritti 1957 – 1984, Milano, Raffaello Cortina, 2005
FRANKL V.E. -Uno psicologo nel lager, Milano, Ares, 2001
LE BRETON D. – La pelle e la traccia, le ferite del sè, Roma, Meltemi, 2005
ROVATTI P. – La follia, in poche parole, Milano, RCS Libri, 2000
TURNER V.- Antropologia della performance, Bologna, Il Mulino, 1993
TURNER V. – Simboli e momenti della comunità, saggio di antropologia culturale, Brescia, Morcelliana, 2003
Folli prìncipi e sovrani (2)
Tarocchi, nudità e follia
Una prima risposta
E’ evidente che ogni possibile contaminazione dell’istituzione col germe della follia coinvolge gli ambiti del sapere e del potere. Il nostro stesso lavoro di operatori deriva da una scelta di metodo operata anni fa da Franco Basaglia che, mantenendo il suo potere di psichiatra per usarlo al fine di riaccompagnare i soggetti internati dentro il corpo sociale, rinunciò contemporaneamente al proprio sapere.
Per dirla con Franco Rotelli, questa rinuncia permise di rendere relativa la follia, ossia di farla sfuggire ai saperi e ai poteri, permettendo ai “corpi reali” di re-identificarsi altrove, rimanendo forse in parte corpi malati, ma corpi vivi (Rotelli, 1998).
La deistituzionalizzazione basagliana è cominciata da questa rinuncia al sapere che ha portato a chiudere le porte dei manicomi aprendo un varco verso i diritti dei soggetti. Tutto sembra essere partito proprio da quel “non so”, ma come si collega questo “non so” con la follia? Torniamo a quei corpi così vicini alla quotidianità di noi operatori per proseguire il discorso appena abbozzato sulle implicazioni relative alla possibile contaminazione dell’istituzione.
Corpi comunicanti
La caratteristica che identifica maggiormente il corpo è la sua esposizione. Il corpo prima di tutto si ex-pone, ossia si mette in mostra all’interno di un sistema di comunicazione. “Esposti” erano i neonati indesiderati, che venivano abbandonati alla provvidenza senza altra proprietà a parte il corpo, neppure quella di un nome o di una genealogia.
Il corpo comunica sempre, lo fa tramite le parole, gli abiti, la gestualità. L’essere umano nasce per comunicare, e questo bisogno è così importante che anche la nudità diventa portatrice di significati. Nelle cerimonie di passaggio presenti in molte culture tradizionali, la spogliazione rituale rimanda alla nascita (o alla rinascita), e viene rappresentata da denudamenti effettivi, o da atti che li simbolizzano, come il taglio dei capelli. Alle nostre latitudini, la nudità si tinge del mito del primitivismo, portandoci ad associare il corpo nudo al vago concetto di “autenticità. “La nuda Verità”, siamo soliti dire, come a coronare l’idea che possa esistere un corpo naturalmente autentico e “vero”. In realtà un corpo “naturale” non esiste. Anche i corpi dei nudisti che si godono il sole estivo traboccano di significati espressi attraverso depilazioni, piercing, pettinature alla moda, tatuaggi oppure attraverso la seconda pelle dell’abbronzatura, uno tra gli ultimi feticci che consolano la nostra endemica paura di castrazione (Baudrillard 1976).
La nudità è sempre significante, anche all’interno del bagno della nostra comunità, o meglio, soprattutto nel bagno della nostra comunità, vista la relazione privilegiata che sembra legare nudità e follia.
Nudità e follia
Il luogo comune del folle che si denuda colto da raptus, è ben presente nella tradizione europea, come ci ricorda il nobile esempio di Orlando, il furioso cavaliere che scorrazzava nudo per le campagne medievali tutto preso a stroncar vite al "populazzo vile". Altri esempi del legame provengono dall’iconografia del primo Medioevo, ove i folli venivano rappresentati nudi o seminudi mentre si portavano appresso una sorta di palloncino, che per alcuni era una zucca vuota, per altri una forma di cacio o un fagottino in cui racchiudere il poco bagaglio necessario al loro girovagare.
La nudità dei folli corrispondeva alla loro esclusione dalla città feudale, e si colorava della diffidenza e del sospetto che la società riservava per loro, e per la nutrita schiera di specialisti del malaffare che ne condivideva il destino; a quanto pare sempre i soliti giocatori, puttane, artisti di strada, ladri e altri derelitti. Miseria e marginalità erano due delle cause principali a determinare la nudità del folle, ma non erano le uniche. Fedeli compagni di via dei folli erano i giullari, gente di spettacolo che campava grazie a bizzarre forme di intrattenimento, come l’esposizione delle proprie nudità al fine di attirare un pubblico grosso per gusti e numero. La nudità che accomunava folli e giullari era dunque, almeno per i secondi, anche un tratto distintivo: un “tratto professionale” che garantiva l’ilarità del pubblico e l’abbondanza di elemosine.
Ma c’è ancora un aspetto da considerare. Durante il Medioevo, forse più che in altre epoche storiche, la foggia dell’abito era un distintivo necessario per potersi inserire all’interno di un mondo gerarchicamente strutturato. I sovrani da cui dipendevano le sorti del regno, portavano precisi segni di identificazione atti a consentire (almeno nella fantasia popolare) il loro riconoscimento in caso di morte (il materiale narrativo legato al rinvenimento delle principessine o dei principi attraverso macchie della pelle, anelli, o scarpine dimenticate, è probabilmente legato a questa necessità pratica).
Quello che valeva per i sovrani valeva anche per le altre classi sociali, come dimostrano i pittoreschi abiti che, anche oggi, possiamo apprezzare addosso ad alcuni membri di congreghe religiose monoteiste di tendenze assolutistiche, o nelle frequenti rivisitazioni storiche che vengono celebrate nell’italico Stivale. Tutto e tutti dovevano poter trovare posto nel rigido e gerarchico mondo del primo Medioevo subordinato alla fede in Dio e alle bizze dal castellano.
Dialettica e follia
La nudità del folle, in un sistema così rigido, aveva dunque anche un ulteriore significato simbolico: ne sanciva l’esclusione dai codici sociali e dalle comuni regole di comportamento. Tale esclusione non appartiene solo a tempi tanto lontani e bui. Prima della Legge 180 infatti, gli internati dei reparti manicomiali, pur se interrogati incessantemente dagli sforzi terapeutici della psichiatria, erano sostanzialmente esclusi dalla dialettica sociale e privati del diritto di cittadinanza (per Pinel, il padre di tutti i manicomi, l’esclusione del contatto tra “sani” e “malati” era da considerarsi come una efficace pratica terapeutica). Come nel Medioevo, anche in tempi più recenti, tale isolamento sembra sottacere la paura di contagio con la follia, da parte di una società rigidamente chiusa nei propri costrutti e incapace di aprirsi a una riformulazione dinamica dei suoi valori.
Non è un caso se l’immagine del folle nudo che caratterizzò il primo Medioevo, prese a modificarsi durante la “rinascita medievale”, periodo caratterizzato dal progressivo abbandono del sistema feudale, che consentì alla società europea di aprirsi a nuovi poteri sociali. Durante quegli anni fu in particolare l’autorità ecclesiastica a cedere terreno al potere imperiale, alla borghesia e alle masse di lavoratori che si riversavano a cercar lavoro dalle campagne alle città. All’interno di questo fremito di ridistribuzione e di ridiscussione dei poteri, assieme alle nuove figure professionali che si affacciano nella città possiamo finalmente trovare anche il folle.
Come chi viene invitato a un convivio, anche il folle risponde alla chiamata rivestendosi, ma non si accontenta dei panni dell’uomo qualunque, come in seguito vedremo, e mira più in alto, ai panni dello stesso sovrano. Ciò che qui ora preme rimarcare, è che pare che sia stata proprio l’apertura della città alla nuova dialettica di poteri ad aver consentito, anzi, ad aver quasi avuto bisogno della presenza della follia.
Buffoni di corte
Abbiamo già notato una prima analogia tra il giullare e il folle in rapporto alla comune nudità. Nel corso del Medioevo le somiglianze aumenteranno progressivamente, portando a una vera e propria identificazione tra il folle e il buffone, il giullare specializzato nell’arte della satira e nella derisione dei costumi.
Foucault osserva come, nel corso del medioevo, la follia salga in cattedra diventando maestra di morale in opere quali La nave dei folli di Sebastian Brant, o L’elogio della follia di Erasmo. Contemporaneamente, osserviamo noi, la follia scende nelle strade e nelle piazze grazie alle rappresentazioni delle compagnie di buffoni, che fino alla Controriforma organizzarono le più importanti feste popolari d’Europa, in particolare quelle che celebravano l’inversione dei valori e il ribaltamento del mondo.
In queste feste di cui il Carnevale contemporaneo è solo uno sbiadito ricordo, la follia e il riso la facevano da protagonisti, e il buffone, utilizzando entrambi, si proponeva come arbitro di un contraddittorio che sottintendeva sempre un possibile ribaltamento, un rimaneggiamento, o un rafforzamento delle gerarchie di valori presenti.
Istituzioni analoghe ai buffoni medievali, erano presenti anche in popolazioni molto distanti dalle nostre. Tra i Pueblo della California, ad esempio, il fenomeno del clownismo rituale venne osservato sovente dai bianchi, che si sorprendevano di come il comportamento alla rovescia di questi individui fosse sorprendentemente analogo a quello del buffone nostrano.
Il loro comportamento era molto vicino a ciò che noi tuttora intendiamo per follia: si esprimevano a gesti, alteravano la voce producendo versi in farsetto, dicevano corbellerie prive di senso, compivano cose contro cultura, giravano nudi, ubriachi e si intrattenevano in grandi abbuffate dei propri escrementi, atti di cannibalismo e frequenti atti di sodomia.
Inoltre costoro godevano di un potere temuto, che si avvaleva del riso di derisione come fosse un’arma di controllo sociale, rivolgendo l’ilarità comune verso alcune categorie osteggiate quali gli infermi, i vecchi e gli ubriaconi. A questa funzione derisoria del riso se ne associava anche una propiziatoria; infatti il loro ridere portava una coesione sociale che facilitava il fatto di trovare soluzioni alle situazioni di crisi (come carestie o mancati raccolti) per cui venivano indette le feste dei buffoni.
Ridiscutendo e riconfermando gli assunti della propria cultura attraverso la loro “follia”, costoro divenivano una sorta di guida che permetteva al gruppo di auto rappresentarsi, di pensare “al suo prima di sé o al suo fuori di sé” (Mazzoleni, 1973) entro i modi del rito e del mito.
I buffoni conferivano alla follia una funzione dialettica e conservativa, applicandola sul materiale già codificato dalla cultura di appartenenza, e su gerarchie di valori già affermate all’interno della società. Tale follia non è in sé né le cose che rappresenta e neppure il loro contrario. Essa è piuttosto una funzione di inversione, è il rovesciamento di un discorso in un altro, è un movimento che, rimettendo il senso delle cose in circolo, ricrea e riformula i valori che lo costringono. La follia, quel “non so” di cui si è detto, sembra essere qualcosa che inverte valori e istituzioni cercando di spostarli verso una nuova ridefinizione e ponendosi in definitiva come il motore di un atto intrinsecamente politico.
Il trionfo del folle
Molte conoscenze che oggi possediamo sull’iconografia medievale del folle le dobbiamo alle carte dei trionfi, più note con il nome di tarocchi. Queste carte, la cui origine si smarrisce tra le nebbie del mito, sono una tra le testimonianze più interessanti circa la nudità della follia e il suo progressivo rivestirsi col vestito del buffone.
Quella del Matto, è una carta fondamentale all’interno del mazzo degli Arcani maggiori, in cui viene numerata indifferentemente col numero zero (come prima carta), col ventidue (ultima carta del mazzo), o non viene numerata affatto.
La figura è in sostanza il perno attorno al quale l’intero mazzo può girare, aspetto che in qualche modo le rimane proprio anche nelle moderne carte da Scala Quaranta in cui la Matta può rappresentare tutti gli altri valori incluso il Re, ma non ne possiede uno proprio e da sola non vale nulla.
E’ inoltre una carta che può permettere di ribaltare le sorti di una partita attraverso combinazioni inedite e svincolate, ma pur se molto pronunciata rispetto alle normali figure, la sua apparente libertà di azione non è mai assoluta. In primo luogo dipende, come già visto, dal valore delle altre carte, secondariamente dipende dalle stesse regole del gioco e dall’andamento della partita. Insomma, pur essendo la carta più libera del mazzo, il valore della Matta dipende dalle relazioni presenti in un dato momento della partita (la situazione delle varie sequenze di gioco), e dalle regole che determinano tali relazioni.
Ancora una volta ci troviamo davanti a una situazione simile a quella raffigurata da Dürer nella Nave dei folli di Brand, la presenza della Ruota della Fortuna (simbolo di ribaltamento dei valori per eccellenza) sembra suggerirci che la follia si può intendere come qualcosa che gioca coi significati acquisiti rimettendoli in discussione (e perché no, in gioco), ma mantenendosi sempre all’interno di un contesto normativo in cui lo stesso ribaltamento pare essere incluso in modo costruttivo e funzionale.
Verrebbe a questo punto provocatoriamente da chiedersi se in realtà Basaglia, adottando il “non so” come pratica deistituzionalizzante, non si sia in realtà limitato a togliere la museruola del pregiudizio medico alla follia rimanendo semplicemente ad ascoltare la sua parola, che altro non può essere se non conflittuale e dialetticamente contraddittoria nei confronti di ogni istituzione umana.
Bibliografia
BACHTIN M., L’opera di Rabelais e la cultura popolare: riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, Einaudi, Torino, 2001
BAUDRILLARD J., Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano, 1976
BERCÉ Y. M., Il re nascosto: miti politici popolari nell’Europa moderna, Einaudi, Torino, 1996
BRANT S., La nave dei folli, Spirali, Milano, 2002
CAMPORESI, P., Rustici e buffoni: cultura popolare e cultura d’élite fra Medioevo ed età moderna,Einaudi, Torino, 1991
CECCARELLI F., Sorriso e riso,saggio di antropologia bisociale, Einaudi, Torino, 1988ù
CLASTRES P., Archeologia della violenza e altri scritti di antropologia politica , La salamandra, Milano, 1982
DRUMBL J., Il teatro medievale,il Mulino, Bologna, 1989
ERASMO, Elogio della follia, Einaudi, Torino, 2002
FOUCAULT M.,Storia della follia nell’età classica, Rizzoli, Milano, 1998
FREUD S., Il motto di spirito, Bollati Boringhieri, Torino, 1991
LE BRETON D., Immaginari della fine del corpo, in Aut Aut n° 330, Il saggiatore, Milano, 2006
MAZZOLENI G., I buffoni sacri d’america, Bulzoni Roma, 1973, p. 22
PROPP V. J., Morfologia della fiaba: Le radici storiche dei racconti di magia, Newton & Compton, Roma, 2003
ROTELLI F, Dietro le mura nascono i mostri, Intervento al convegno di “psichiatria e architettura” del 1992, in Microtesti, Mantova
SCHMITT J., Il gesto nel Medioevo, Laterza, Bari, 1990
SCIACCHITANO A., Il corpo pensante, in Aut Aut n° 330, Il saggiatore, Milano, 2006
STAROBINSKI J., Ritratto dell’artista da saltimbanco, Bollati – Boringhieri, Torino, 1984
Folli prìncipi e sovrani (3)
Detronizzazioni
«Avec moi c’est l’absolu ou rien» (A. Artaud)
Tristano e Isotta
E’ il caso di chiudere questo giro per le strade del Medioevo con un documento che parla proprio del rivestirsi della follia; si tratta della leggenda di Tristano e Isotta, i due sfortunati amanti protagonisti delle saghe del mitico re Artù. La leggenda, prima di conoscere i torchi tipografici di Parigi nel 1508, venne a lungo tramandata in forma orale e fu raccolta in un vasto ed eterogeneo materiale manoscritto tra il sec. XII e il XIII: “La Folie Tristan”, contenente tratti della cultura aristocratica oltre che motivi popolareschi tratti da “naviganti, da monaci, da conversazioni tenute nelle corti e coi giullari” (Panini, 1951).
Delle due più antiche versioni, riprendo qui quella di Oxford, nella traduzione e negli illuminanti commenti del medievalista Paolo Galloni, che interpreta la vicenda come metafora di “una delle ossessioni medievali per eccellenza: ovvero l’eredità e la successione. La figura principale della leggenda è il giovane principe Tristano, che dopo essere stato nominato cavaliere dallo zio Marco di Cornovaglia si reca in Irlanda al fine di accompagnare a corte la promessa sposa del re: la bella principessa Isotta la Bionda.
Ma come spesso accade nelle fiabe, anche questa volta qualcosa va storto, e i due giovani, per aver incautamente bevuto un filtro magico, si innamorano fatalmente l’uno dell’altra. Il tradimento viene presto scoperto da re Marco e i due amanti si rifugiano nella foresta, dove vengono nuovamente scovati mentre riposano castamente.
Marco si allontana senza svegliarli, lasciando sulla scena la spada e l’anello nuziale. Al loro risveglio i due amanti, colpiti dalla generosità del re, decidono di separarsi: l’una torna dal suo sovrano, l’altro si accasa con un’altra Isotta omonima dell’amata e a lei straordinariamente somigliante. Ma il delirio amoroso non libera Tristano, e il giovane, non potendo fare a meno di desiderare l’amata, sarà costretto a fare spesso ritorno da lei in Cornovaglia sotto mentite spoglie (mendicante, lebbroso, pazzo), fino all’immancabile esito della vicenda. Secondo un tragico cliché, sarà la morte a riunire per sempre i due amanti.
La follia di Tristano
E’ la parte centrale della vicenda a interessarci maggiormente, ossia il folle amore di Tristano per Isotta, che rappresenterebbe simbolicamente la stessa Istituzione monarchica. Tristano si getta ambiziosamente nella sfida d’amore, senza altri vedere che “sé stesso accresciuto in posizione di potere” (Galloni, 2004), ma non riesce nell’impresa di togliere di torno il re, ereditandone trono e moglie. Smascherato nel suo amore segreto, Tristano prima scappa dal regno di re Marco e poi, spogliatosi degli abiti di cavaliere, impazzisce del tutto e vive una tormentata serie di peripezie: vaga nudo per la foresta, mangia carne cruda, e si confonde con i pazzi e coi cinghiali.
Proprio lui, che un tempo fu il prototipo del cavaliere perfetto, smette la maschera della civiltà lasciando esplodere il suo aspetto bestiale; abbandona il cavallo e vaga a piedi per i luoghi marginali e inabitati della foresta ove, armato di una primordiale mazza, si alimenta di cibi crudi che non hanno conosciuto nessuna “cottura simbolica” (Levi Strauss, 2004). In poche parole, Tristano, impazzendo, sembra tornare a un livello preculturale, e come avviene per il matto dell’Alto Medioevo, si spoglia di ogni legame con la società umana, correndo nudo per le lande marginali e selvagge della natura.
Ma il richiamo per l’amata Isotta (l’umana aspirazione al potere) è troppo forte, e Tristano ritorna nelle terre del re Marco via mare, come accadeva per i Narrenschiff, le mitiche navi dei folli, che durante il Medioevo approdavano col loro destabilizzante equipaggio nelle città fluviali del Nord Europa. Lo sbarco nel regno dello zio segna per Tristano una sorta di rinascita. Si tratta di rinascita molto pericolosa però, perché re Marco lo odia più di ogni altra cosa al mondo e, se lo catturasse, certo non gli risparmierebbe la vita (Galloni, 2004).
Lo specchio del re
Come per il matto medievale, che indossa gli abiti rientrando in città, anche per Tristano, il gesto che sancisce il ritorno alla civiltà è quello della vestizione. Dovendo trovare uno stratagemma per introdursi a corte, egli sfrutta l’antica usanza che imponeva l’accoglienza nei confronti dei miseri e dei mendichi. Indossa così gli abiti di un pescatore e, dopo essersi tonsurata una croce sulla testa, ruba un paletto da uno steccato per aggiungere l’ultimo orpello al suo camuffamento, che somiglia ormai in modo notevole a quello di un buffone. Lui stesso ammette: “Pazzo sono e da pazzo agirò”.
Così conciato entra nel palazzo del sovrano proprio nel bel mezzo di un banchetto. L’attenzione degli invitati si sposta immediatamente su di lui, ma nessuno lo riconosce. “Ecco il matto! Hu! Hu! Hu!”, gridano a un certo punto i valletti e gli scudieri lanciandogli addosso scorze di legno e seguendolo, in disordinato corteo, fino al cospetto del sovrano. E’ presso re Marco, infatti, che Tristano trova posto a sedere mentre nessuno ancora lo identifica, lasciandolo libero di compiere la sua delirante impresa.
Tristano, ormai morto come successore di re Marco a causa del tradimento, è contemporaneamente rinato come buffone e come tale può essere nuovamente accolto a corte. Il folle Tristano prosegue a comportarsi come un sovrano durante tutto il banchetto, e nel cuore della festa propone in sposa allo zio una sua presunta sorella, chiedendo in cambio la mano di Isotta. Il re risponde con una sonora risata e continua a non accorgersi che sotto le spoglie del folle si cela il nipote. Solo alla fine della sceneggiata Isotta riconoscerà Tristano mentre porta a termine la sua rinascita: l’erede fallito che sfugge dall’indeterminatezza del suo ruolo coronando, in forma di parodia, il suo sogno di potere.
Il riso e la morte
“Suono l’arpa e la crotta, e nessuno mi è pari nel canto. Io so amare le regine, non c’è al mondo amante che mi eguagli. So intagliare i ramoscelli e gettarli nei ruscelli. Maestà, non sono un buon menestrello?” dice a un certo punto il giovane rivolgendosi al sovrano. Con tali parole, Tristano sembra riconoscere definitivamente il proprio status; a loro conferma prende a scimmiottare il re, ordinando ai commensali di allontanarsi dalla tavola e scatenando l’ilarità generale.
La croce sul capo evoca la corona del sovrano come i cenci da pescatore e il pezzo di legno ne richiamano abito e scettro. E’ la prima volta che il vincitore e lo sconfitto possono trovarsi uniti in modo speculare al cospetto dell’amata Isotta, e il gioco di specchi tra i due prosegue durante tutto il banchetto. Si tratta però di specchi che, rifrangendo la figura dello zio in quella del folle nipote, non possono che tener conto dell’irrimediabile distanza che ora li separa.
Tale distanza sottace due morti mancate: quella a cui scampa Marco, che Tristano avrebbe dovuto spodestare per procurarsi trono e regina, e quella che minaccia ancora il giovane folle, che, allontanato dal regno sotto pena capitale e ormai irrimediabilmente bandito dalla scalata al trono, potrebbe venire scoperto e giustiziato in qualsiasi momento.
E’ solo la follia che ora può salvare la situazione, permettendo che si compia l’impossibile. Tristano gioca l’unica mossa che gli può permettere di restare in contatto con l’amata e impazzisce. Mettendosi in gioco come la Matta delle carte, costui riesce a sostituirsi al sovrano rispecchiandone l’aspetto tragico in quello, comico, proprio del buffone. Infatti, mentre Marco, nel pieno delle sue facoltà di sovrano, ordina e gli altri eseguono, Tristano ordina e gli altri ridono. Impotente rispetto al sovrano, Tristano gli è ormai legato da un fallito tentativo di sovversione che viene esorcizzato (e rievocato) dal riso. Anche il riso che unisce i due è in fondo un riso asimmetrico, che comporta un rapporto di dominanza esplicito.
Il re domina due volte Tristano: col proprio potere e col proprio riso. Certo, Tristano fa ridere gli astanti imitando il sovrano, ma il suo riso, nascondendo un’usurpazione fallita, dichiara contemporaneamente la propria impotenza nel rovesciarlo. E’ il re che, deridendo il vecchio rivale ridotto ormai all’impotenza, continua a disporre del proprio potere, tanto da potersi allontanare dalla scena senza timori, lasciando che il folle concluda, inascoltato, l’inutile parodia.
Il riso del folle presente in questa scena gioca ancora una volta col sovvertimento dei valori. E’ piuttosto evidente la sua portata destabilizzante e le minacce che sottintende: da una parte il tirannicidio (sempre quel “non so” in cui la follia emerge pienamente nella sua valenza politica e dialettica), dall’altra la potenziale, ma incompiuta, soppressione del pretendente, ossia l’affermazione del vecchio potere. Ancora una volta pare che la follia si diverta a prendere di mira i valori che si considerano socialmente condivisi, cercando di sovvertirli o, se non altro, di metterli alla prova.
Un re in bilico
L’aspetto metamorfico di re Marco, significa dunque che la sua legittimità a regnare deve essere appurata, e ciò può avvenire solo attraverso il tentativo di usurpazione a cui è funzionale la figura di Tristano. Se ci spostassimo dalle gerarchie politiche alle gerarchie socio culturali, potremmo vedere re Marco come un valore condiviso la cui validità, essendo posta in dubbio, andrebbe poi verificata dalla comunità.
E’ ora necessaria una precisazione che ci aiuterà a comprendere meglio tutte le implicazioni della leggenda e le suggestioni che questa può fornirci. Il re Marco, il cui nome deriva dal bretone “Marc’h”, che rimanda a una voce celtica significante “cavallo” (facilmente sovrapponibile al nome Marco di origine latina), è un sovrano piuttosto anomalo. Oltre a non rispettare i costumi regali antichi (uno per tutti, il fatto che chieda al nipote di procacciargli moglie, Galloni, 2004), costui è afflitto di un mostruoso difetto. Si tratta di un paio di orecchie animali (in genere di cavallo o di somaro) che, secondo la leggenda, gli decorano la testa coronata. La peculiarità non è affatto casuale ed è comune anche ad altri sovrani dei miti greci (re Mida, ad esempio), celtici, e di altre leggende popolari. Ove presente, l’attributo animale implica sempre l’appartenenza del sovrano alla sfera dell’ibrido, ossia a una condizione transitoria e impura che richiede di essere ricodificata entro forme più definite e rassicuranti.
Premessa per ingenue conclusioni
Come nei capitoli precedenti, anche in questo sono andato cercando una risposta a domande nate durante il mio lavoro di operatore. Domande che mi hanno condotto verso questa “ingenua” ricerca sulla follia (né medica, né specialistica dunque) che da tempo accompagna l“ingenua professionalità” con cui, fin dai primi il giorni di lavoro, mi sono immerso in quello strano mondo che era, allora, il manicomio in saldo.
E’ questo sguardo ingenuo che spesso ho rivolto ai rapporti e alle dinamiche esistenti fra noi “addetti ai lavori”. La follia, per come l’ho conosciuta, mi è sembrata sempre un fenomeno relazionale; una forma di comunicazione fondamentalmente e inevitabilmente umana, un linguaggio in cui sono entrato anche io col mio ruolo di operatore. Non ci sono certezze (che neppure mi competerebbero) in queste pagine, come non c’è certezza nel mio lavoro. Ingenuità, appunto, rimandando a quell’in- gǐgnere, quel “nascere dentro” che in latino implicava la nascita da genitori liberi, e che si confonde nella radice di un’altra parola, tanto vicina nell’etimologia quanto nel nostro lavoro quotidiano: ingegnosità.
E’ forse di questa “ingenua ingegnosità” che mi avvalgo, quando proseguo il mio cammino in compagnia di madama Follia, cercando di mantenere aperto il guscio del mio ruolo alla radicale e nuda alterità che mi attende al di fuori dei miei confini, e che a volte entra a rubarmi gli abiti, spogliandomi delle mie instabili certezze.
Conclusioni
Esiste la possibilità che l’istituzione si contamini col germe della follia?
Nella leggenda di Tristano, l’unica risposta certa sembra essere che la de-istituzionalizzazione di cui stiamo trattando non è da intendersi tanto come una distruzione, quanto come una sorta di manutenzione dell’istituzione, che interviene nel momento in cui il vecchio sovrano (il vecchio valore) non ha più efficacia e dignità a regnare. Indipendentemente dall’esito dello scontro, la funzione regia sarebbe sopravvissuta, comunque, come di fatto avviene, in uno dei due contendenti.
Inoltre, come dimostrano i riti dei buffoni rituali Kachina riportati nel capitolo precedente, quanto visto è funzionale alla conservazione delle dinamiche sociali. La follia rivestita si inscena qui con prepotente valenza relazionale. Essa include infatti nel suo codice comunicativo il re, il pretendente, Isotta, e soprattutto la corte (la società), che è chiamata a partecipare attivamente a ciò che accade.
A ben vedere, in questa potenziale perdita di dominio, ritroviamo più di qualche analogia con la costante sfida a cui sono sottoposte le nostre gerarchie di valori mentre compiamo il nostro lavoro. Questa sfida interiore non è poi dissimile da quella in atto tra il vacillante re Marco e Tristano, e rappresenta in modo concreto l’altrimenti impersonale processo di de-istituzionalizzazione implicato dal “non so” filosofico da cui eravamo partiti.
Come un cristallo che infrange una luce irradiandone lo spettro di colori, la riforma basagliana ha riaperto, nel grembo della società, innumerevoli domande che nascono costantemente dal confronto con la follia. A queste domande sembra non si possa rispondere definitivamente, data la loro capacità di evocare sempre ulteriori significati che, fortunatamente, allontanano il ritorno monocolore della psichiatria contenitiva.
Non rimane allora che chiudere questo ultimo capitolo con due domande piuttosto che con due risposte. Alla luce della leggenda, verrebbe infatti da chiederci se noi operatori psichiatrici, figure chiave della deistituzionalizzazione, siamo sufficientemente inseriti (ed accolti) entro un pubblico scenario, una corte, una comunità, un convivio che possano assistere (con tutte le sfumature che la parola comporta) alla nostra opera di quotidiano dialogo con la follia. E ancora… verrebbe da interrogarsi su quanto noi, ultime ruote dell’istituzione, mentre vacilliamo a causa dello spiazzamento che comporta la nostra de-istituzionalizzazione, siamo in grado di raccogliere pro-positivamente la sfida. In poche parole: fino a che punto siamo disposti e preparati al rischio di venire scalzati dal trono e precipitati dentro l’ignoto abisso che si aprirebbe in noi dopo la vittoria di Tristano?
Bibliografia
AAVV Il bello e le bestie: metamorfosi, artifici e ibridi dal mito all’immaginario scientifico, Skyra, Ginevra-Milano, 2004
AARNE A. – THOMPSON S., Types of the Folktales, Academia scientiarum Fennica, Helsinki, 1928
BASILE G., Echi della leggenda del re Mida con le orecchie d’asino, “Lares” n° 37, 1971
CAPALBO G., Una leggenda popolare classica, “La Calabria”, Monteleone (oggi Vibo Valenzia) anno XI, n°2, 1898
CARDINI, F. L’asino, in Mostri, belve, animali nell’immaginario medievale/ 5
www.airesis.net/IlGiardinoDeiMagi/Giardino%201/cardini_2_%20enciclopedie.htm
CORTELAZZO M., Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Milano, 2000
DOUGLAS M., Purezza e Pericolo, Il Mulino, Bologna, 1975
DURKHEIM E., Le origini dei poteri magici, Boringhieri, Torino, 1972
FERIGO G., I nuviz, la fantasima, il mus. Note sull’interdizione matrimoniale di maggio, in “Ce fastu?”, LXXIV, (1998), 2, pp.199-251
FRAZER J. C., Il Ramo d’oro, Newton & Compton, Milano, 1992
GALLONI P., in Studi Celtici, Edizioni dell’Orso , Alessandria, N°III, 2004
GRIMAL, P. Enciclopedia della mitologia, Paideia – Garzanti, Brescia, 1999
JENKYN W.T., The Welsh Fairy Book, London, 1908
KENNEDY. P, Legendary Fictions of the Irish Celts, London and New York, 1891
LAPLANTINE F., Antropologia della malattia, Sansoni Editore, Firenze,1988
LEVI STRAUSS C., Il cotto e il crudo, il Saggiatore, Milano 2004
LEVI STRAUSS C., Il pensiero selvaggio, Mondadori,Milano 1990
MAUSS M., Teoria generale della magia: e altri saggi, Einaudi, Torino, 1965
LIONETTI R., Medici, stregoni ed altri guaritori: temi di antropologia medica ed infermieristica, Paolo Deganutti, Trieste, 2002
PANVINI B, La leggenda di Tristano e Isotta, Olschki, Firenze, 1951
PELLIZER E., La peripezia dell’eletto,Sellerio, Palermo, 1991
VAN GENNEP A., riti di passaggio, Boringhieri, Torino, 1981
Articolo di Federico Galvani da Itaca