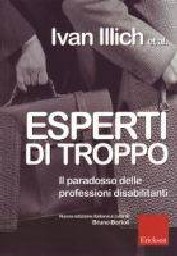 Tutti i processi di medicalizzazione hanno conseguenze di tipo politico, anche se ci sforziamo tutti di negarle. Si parla sempre più spesso di salute e di malattia, in termini metaforici, per contribuire a spiegare – o per spiegare tout court – i problemi sociali più diversi. Basta sfogliare una delle ultime annate del «New York Times» per trovare commenti di tipo medico, o psichiatrico, in merito a una grande varietà di fenomeni: divorzi, tumulti razziali, black power, delinquenza giovanile, matrimoni misti, utilizzo di eroina, LSD e marijuana, abbandoni scolastici, mancanza di rispetto dei figli per i genitori, hippies, attivisti dei diritti civili, proteste studentesche, dimostrazioni contro la guerra, critiche alla medicina, astensionismo elettorale, nuove forme di opposizione, emancipazione femminile.
Tutti i processi di medicalizzazione hanno conseguenze di tipo politico, anche se ci sforziamo tutti di negarle. Si parla sempre più spesso di salute e di malattia, in termini metaforici, per contribuire a spiegare – o per spiegare tout court – i problemi sociali più diversi. Basta sfogliare una delle ultime annate del «New York Times» per trovare commenti di tipo medico, o psichiatrico, in merito a una grande varietà di fenomeni: divorzi, tumulti razziali, black power, delinquenza giovanile, matrimoni misti, utilizzo di eroina, LSD e marijuana, abbandoni scolastici, mancanza di rispetto dei figli per i genitori, hippies, attivisti dei diritti civili, proteste studentesche, dimostrazioni contro la guerra, critiche alla medicina, astensionismo elettorale, nuove forme di opposizione, emancipazione femminile.
Non voglio qui entrare nel merito della questione se le femministe o i protagonisti della contestazione siano affetti da malattia. Mi interessa, invece, ciò che accade non appena su un problema – e su coloro che ne sono coinvolti – si applica l’etichetta di «malattia».
Adottare questa etichetta porta inevitabilmente a collocare la fonte essenziale dei problemi, e quindi il focus del trattamento medico, nei singoli individui. Il problema che li riguarda viene così ad assumere un’eziologia asociale e impersonale: come se si trattasse di un batterio velenoso o di uno scompenso ormonale. Ciò può servire, in termini pragmatici, a meglio gestire una specifica malattia organica, laddove un problema sociale viene fondamentalmente ricondotto al singolo individuo o alla cerchia immediata di chi vive con lui.
Accanto a questo, ha la funzione di celare ai nostri occhi verità più importanti e sconcertanti. Ciò che è «malattia» non può, per definizione, essere sociale; né può essere sociale l’approccio di intervento che ne deriverà. Il problema, così individuato, può essere gestito in un contesto qualunque, e le responsabilità al riguardo ricadono sugli individui – di solito coloro che «hanno» il problema stesso – e non su tutti gli altri, o sulla società in senso ampio. In questo senso, viene molto più facile considerare Hitler e i nazisti come una banda di psicopatici, che hanno dato vita alla seconda guerra mondiale e hanno modernizzato l’idea stessa di «genocidio», anziché interrogarsi sulle responsabilità di quaranta milioni di tedeschi e di un mondo che è rimasto a guardare.
Allo stesso modo, è più rassicurante fare speculazioni sulla malattia di un certo capo di stato corrotto, e sulle nevrosi e le paranoie di chi gli stava intorno, che non chiedersi che tipo di sistema sociale, economico e politico abbia prodotto delle persone del genere.
Un altro aspetto che affascina del modello medico è dato dalla sua presunta neutralità morale. Derivano proprio da questo le maggiori possibilità di offuscare le questioni morali. La malattia, dal punto di vista di un medico, diventa qualche cosa di doloroso e indesiderabile; qualche cosa che, come tale, può e dovrebbe essere eliminato. È per questo che occorre molta cautela nel formulare un’equazione tra lo stato di malattia e i problemi sociali, o i fenomeni sociali più spiacevoli. Se di malattia si tratta – individuale o sociale che sia – va eliminata per definizione, quale che sia la volontà del diretto interessato.
Vale la pena di riflettere ancora su quest’ultimo aspetto. Il processo di etichettamento di un problema sociale in termini di malattia fa leva su un drastico squilibrio di potere. La malattia, infatti, può essere diagnosticata e curata soltanto da certe figure professionali, con una specifica qualifica e un mandato ben preciso; in primo luogo, i dottori.
Data la premessa, il potenziale paziente non ha grandi diritti a obiettare all’etichetta che riceve. Laddove, invece, ha da ridire sul trattamento che riceve, non mancano le soluzioni retoriche per ridimensionare la questione: poiché è malato, non ha le idee ben chiare su quello che va meglio per lui; né sa, tanto meno, se si stia comportando davvero «bene». Chi formula la diagnosi, invece, non ha alcun dubbio al proposito. Dalla sua, infatti, ha un expertise che, in virtù della sua legittimazione sociale, dà un tono di neutralità morale ai suoi giudizi.
A ben vedere, però, un ragionamento di questo tipo è profondamente ingannevole. Ammesso anche che la diagnosi di una malattia, e gli strumenti su cui si basa, appaiano moralmente neutri – cosa su cui nutro seri dubbi –, la decisione circa la rilevanza di un determinato problema sociale non è priva di conseguenze morali. Si tratta di una decisione che non è moralmente neutra, proprio perché, nello stabilire la rilevanza del problema in questione, si stempera – e a volte si previene tout court – qualsiasi questione di ordine morale. Se si accetta che un determinato comportamento equivale a una malattia, e che una malattia è uno stato di per sé indesiderabile, la questione non è più se affrontare il problema, ma come e quando. Il dibattito su temi come l’omosessualità, la droga, l’aborto, i bambini iperattivi, i comportamenti antisociali, finisce così per concentrarsi sul grado di malattia insito nel fenomeno in questione, o in chi ne è «portatore»; o, per dirla diversamente, sull’entità del «rischio per la salute» che ne deriva. Viene del tutto estromessa, in tal modo, la questione di principio, quella più ambigua, ma di innegabile valenza morale: di che libertà dovrebbe disporre un individuo, rispetto al proprio corpo? E che cos’è che andrebbe curato, al di là dell’individuo in questione?
Irving Kenneth Zola Medici disabilitanti in Esperti di troppo. Il paradosso delle professioni disabilitanti, Erickson, Gardolo (TN), 2008, pag. 67-70
